
Il caso di Giulia Cecchettin, con la sua tragica violenza di genere, ha generato un profondo dibattito sulla necessità di educare i giovani alla non violenza. Nell’epoca attuale, i genitori si trovano ad affrontare un senso di impotenza e disorientamento di fronte alla domanda di quale sia stato il loro operato fino ad oggi. Si ritrovano a chiedersi se i loro figli siano davvero come li hanno immaginati, o se potrebbero essere degli estranei nella stessa casa. I figli, dal canto loro, si pongono domande sulle persone intorno a loro, chiedendosi se qualcuno potrebbe arrivare a gesti estremi.
In questo vortice di interrogativi e incertezze, si fa sempre più evidente la mancanza di dialogo. Tutti cercano colpe da attribuire: la scuola, i genitori, il sistema. Ma ciò che emerge è una “crisi identitaria senza precedenti“, che richiede un’intervento urgente per permeare profondamente le menti dei più giovani.
Il dottor Matteo Lancini, psicologo e psicoterapeuta, presidente della fondazione Minotauro di Milano, sottolinea l’importanza di un’educazione seria, affettiva, sessuale e identitaria, consapevole delle complessità della società contemporanea. Gli adolescenti si trovano ad affrontare modelli di identificazione ambigui e disorientanti, mentre gli adulti non sembrano dimostrare un livello di comprensione emotiva adeguato.
Il caso di Filippo Turetta, accusato dell’omicidio di Giulia Cecchettin, ha sollevato interrogativi sull’urgenza di educare i giovani alla non violenza di genere. È in momenti come questi che emerge la necessità di un approccio educativo che tenga conto della realtà complessa in cui viviamo, un approccio che aiuti a formare menti consapevoli e sensibili nei confronti degli altri.
Il libro del dottor Lancini, “Sii te stesso a modo mio. Essere adolescenti nell’epoca della fragilità adulta”, riflette proprio su questa complessa relazione tra giovani e adulti nella società contemporanea. Emerge la necessità di superare la fragilità emotiva degli adulti per trasmettere ai giovani valori di rispetto e non violenza, con un dialogo aperto e formato.
Dopo quanto è successo, diventa evidente che è fondamentale continuare a promuovere l’educazione alla non violenza di genere. Quali sono i modi migliori per insegnarla ai bambini e ai ragazzi?

Le dinamiche di genere sono solo la punta dell’iceberg, non possiamo limitarci a guardare il problema da un’unica prospettiva. C’è un intreccio intricato di cambiamenti culturali, sociali e tecnologici che stanno ridefinendo le relazioni umane in modi che non avremmo potuto immaginare in passato.
La televisione e i media giocano un ruolo significativo in questo processo. La nostra società è immersa in una costante esposizione a modelli comportamentali e relazionali irreali, quasi inarrivabili. Siamo spettatori di una rappresentazione distorta di ciò che dovrebbero essere l’amore e la coppia, e questo ha un impatto profondo sulla nostra percezione di noi stessi e degli altri.
La questione della fine di una relazione diventa sempre più complessa. Non si tratta più solo di dire addio e andarsene, ma di vivere una fase di separazione che può protrarsi per mesi o addirittura anni. E in questo lungo processo, emergono le difficoltà nel comprendersi e nel gestire le emozioni, così come le tendenze alla violenza e all’aggressività che purtroppo accompagnano molte separazioni.
La risposta non può essere una semplice campagna informativa, il cui impatto spesso si perde nel mare degli stimoli visivi e sonori a cui siamo esposti ogni giorno. Occorre un approccio più profondo, una vera educazione che includa l’affettività, la sessualità e l’identità in modo integrato, a partire dall’infanzia fino all’età adulta. Soltanto così potremo sperare di affrontare in modo efficace le sfide che il mondo contemporaneo ci pone di fronte.
La questione è quindi strettamente legata alla fragilità delle nuove generazioni?
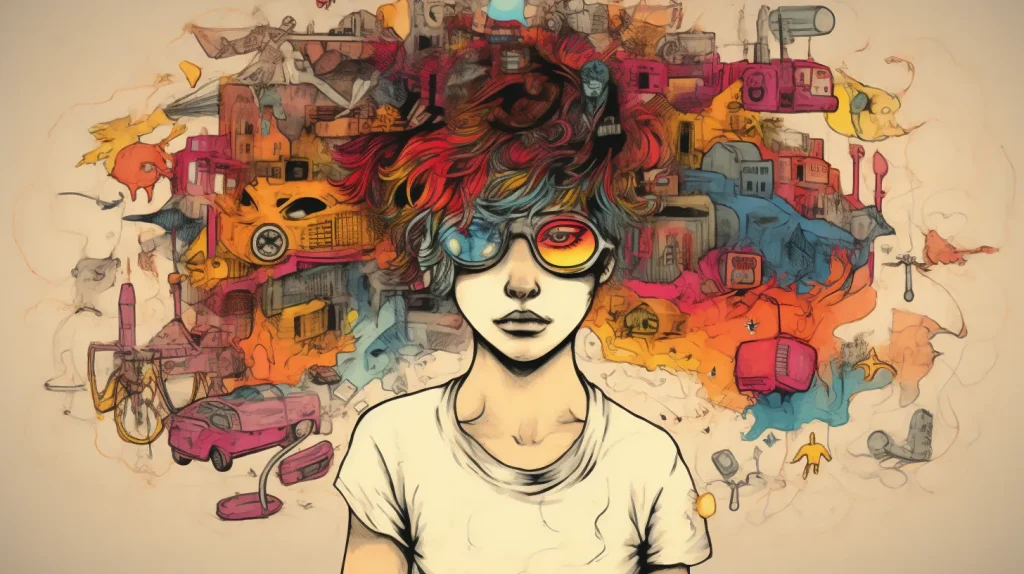
In un groviglio intricato di fragilità e disperazione, si dipana il filo sottile della vita umana. Quadruplo, perché intessuto di tante sfaccettature, di tanti nodi irrisolti. La fragilità si manifesta in forme svariate, in una danza tragica e intricata che porta alcuni a spezzarsi, come rami secchi in una tempesta.
I suicidi, veri e propri o travestiti da tragici incidenti stradali, sono l’estremo gesto di chi si sente in trappola, incapace di trovare una via d’uscita. Ma c’è anche chi combatte la propria fragilità con il dolore autoinflitto, i tagli che solcano la pelle come solchi nel terreno arido. E poi c’è il ritiro sociale, l’incapacità di relazionarsi con il mondo, la solitudine che diviene ghiaccio intorno all’anima.
In questa tela intricata troviamo anche la violenza, un filo nero e spesso che scorre tra le pieghe della società. La violenza in strada, un’esplosione di rabbia e frustrazione che si riversa sui più deboli. E poi c’è la violenza verso l’altro, un abisso di oscure pulsioni che portano all’abominio estremo del femminicidio. Una pagina nera nella storia dell’umanità, un’espressione estrema della fragilità che diventa violenza contro chi dovrebbe essere amato e protetto.
Eppure, in mezzo a questa trama intricata di fragilità e disperazione, c’è anche spazio per la speranza. Nelle piccole azioni di gentilezza, nella solidarietà tra sconosciuti, nei gesti di sostegno e comprensione. La vita umana è un intricato intreccio di fragilità e forza, di disperazione e speranza, e spetta a ciascuno di noi tessere un filo luminoso nella trama oscura della vita.
Il prossimo mercoledì, il Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, terrà una presentazione riguardante dei «percorsi di educazione alle relazioni» indirizzati agli studenti delle scuole superiori. Sono necessari ulteriori interventi concreti o quelli proposti sono sufficienti?

Sono convinto che le iniziative rivolte ai giovani debbano partire da un’alfabetizzazione emotiva degli adulti, cioè da una presa di coscienza delle proprie fragilità e da un’apertura al dialogo con le nuove generazioni. Spesso, infatti, tendiamo a scagliare accuse sui giovani senza renderci conto che la violenza e la sopraffazione possono anche derivare dalla mancanza di comprensione e sostegno da parte degli adulti.
In una società sempre più dominata da Internet, ci aggrappiamo all’idea che i ragazzi siano vittime della tecnologia e incapaci di elaborare le proprie emozioni. Tuttavia, dobbiamo considerare che noi stessi adulti spesso viviamo in maniera dissociata rispetto alle esperienze dei giovani, imponendo loro un’educazione all’affettività e alla sessualità in contesti che non riflettono la realtà in cui essi vivono.
Il lavoro con gli adolescenti, dunque, non può prescindere da un’autentica connessione emotiva e dialogica, che li aiuti a esprimere le proprie emozioni e a elaborare i loro stati affettivi. Solo partendo da una maggiore comprensione reciproca potremo evitare che eventi di violenza si ripetano e contribuire alla formazione di individui consapevoli e empatici.
È sensato attribuire il comportamento violento di un figlio a un’ipotetica mancanza di educazione da parte dei genitori o si tratta di una spiegazione troppo riduttiva? È appropriato cercare responsabilità nei genitori?
In un mondo in cui i modelli educativi sembrano fluire da mille fonti diverse, è necessario riflettere su quale tipo di immagini e valori vengano trasmessi alle generazioni future. I genitori, sovraccaricati dalle pressioni della vita moderna, faticano a instaurare vere e proprie conversazioni con i propri figli, costretti a credere che la soluzione al problema dell’educazione sia semplicemente nel limitare l’uso di Internet e dei dispositivi tecnologici. Ma forse, dovremmo guardare a questi strumenti come riflessi ingigantiti delle fragilità e delle insicurezze che già esistono in noi stessi.
Forse è il momento di introdurre un’educazione che vada oltre la mera trasmissione di conoscenze, ma che includa anche i temi dell’affettività, della sessualità e dell’identità, considerando anche le radici profonde del patriarcato e del possesso che caratterizzano la società. È importante aver consapevolezza della mancanza di alfabetizzazione emotiva negli adulti, che spesso si riflette nei modelli educativi trasmessi alle nuove generazioni.
Tuttavia, non dobbiamo cadere nell’errore di generalizzare le esperienze personali, perché ogni storia è unica e va analizzata come tale, senza tentare di comprimerla in schemi preconfezionati.
A partire da quale età sarebbe opportuno iniziare a proporre lezioni di “educazione alle relazioni”?
Era compito del Parlamento prendere una decisione in merito. Ma forse sarebbe stato meglio intervenire già dalle scuole medie, sebbene alcuni sostengano che sia ormai troppo tardi. In ogni caso, se le lezioni si limitano a un’ora a settimana, con il computer spento e un insegnante che entra in classe per ripetere il mantra del rispetto verso gli altri, c’è il rischio che tutto ciò non funzioni o addirittura si riveli controproducente. Se davvero vogliamo ottenere dei risultati, dobbiamo intervenire nella società nel suo insieme, non limitarci a una singola istituzione scolastica in cui un educatore, un pedagogista o uno psicologo impartisce lezioni dall’alto in basso, con il divieto di utilizzare Internet “perché distrae”, annoiando gli studenti dopo pochi secondi, senza riuscire a coinvolgerli e ascoltarli veramente. Ecco perché ritengo tanto urgente l’alfabetizzazione emotiva degli adulti.
È facile entrare in classe e lanciare slogan come “uomini e donne hanno gli stessi diritti”, “la violenza è sbagliata”, “una donna non si tocca neanche con un fiore”. Ma se continuiamo a pensare che sia sufficiente organizzare conferenze in classe per risolvere il problema, assisteremo sempre più spesso a eventi come questo, perché la radice del problema risiede in una crisi identitaria senza precedenti, soprattutto nel maschile, e in una violenza intrinseca alla società stessa. Dobbiamo trovare il modo di aiutare i ragazzi a non farsi trascinare in questa spirale di violenza.
La vita, osservata con occhio critico da un narratore calviniano, è spesso il riflesso delle contraddizioni e delle vicissitudini dell’uomo. La scuola, luogo privilegiato di formazione e confronto, non può prescindere dall’analisi e dall’intervento sul tessuto sociale più ampio, altrimenti rischia di rivelarsi impotente di fronte alle grandi sfide educative. La parola chiave è ascolto: ascolto degli studenti, delle loro paure e desideri, ma anche ascolto della società nel suo complesso, per individuare le radici profonde di problematiche come la violenza di genere. Solo così si potrà sperare di influire in modo significativo sul destino dei giovani e sulla costruzione di una realtà più equa e inclusiva.
Quali sono i segnali, anche quelli che sembrano innocui, che possono essere indicativi della presenza di un disagio o di un campanello d’allarme?
Era una domanda che si ripeteva da 31 anni, fin da quando aveva iniziato la sua carriera di psicologo. Gli casi di ritiro sociale, suicidio, autolesionismo: tutti fenomeni che si manifestavano improvvisamente, lasciando attoniti genitori, amici, insegnanti. Eppure, anche se i campanelli d’allarme sembravano così evidenti a posteriori, raramente venivano percepiti in anticipo.
Non ci si poteva dare colpe, davvero. I genitori di quei ragazzi non avevano intercettato né sottovalutato il disagio che covava nelle menti dei loro figli. Non si poteva pensare di giudicarli, di additarli come responsabili di ciò che era accaduto. Ed era esattamente questa mancanza di certezze, questa impossibilità di individuare chiavesi e risposte chiare, a colpire l’opinione pubblica.
La percezione che lui fosse un “ragazzo come tanti con qualche timidezza” era ciò che aveva scatenato il dibattito in tutti i salotti televisivi e le conversazioni al bar. La gente si chiedeva come avesse potuto succedere qualcosa del genere a uno di quei ragazzi apparentemente normali, senza segni evidenti di squilibrio o disagio.
Ma la realtà era che nessuno poteva dirsi al riparo da simili eventi. La mente umana era un labirinto oscuro e impenetrabile, e anche coloro che sembravano più equilibrati potevano nascondere angoli d’ombra inimmaginabili. Non c’era persona al mondo che potesse escludere a priori di trovarsi di fronte a un simile enigma, né singolo o collettivo che fosse.
Era proprio questa consapevolezza dell’imprevedibilità della vita a rendere ogni singolo istante così fragile e prezioso. E proprio per questo motivo, nonostante la tragedia e il dolore inspiegabile, c’era ancora il bisogno impellente di cercare un senso, di aggrapparsi a qualcosa che potesse darci una spiegazione, anche se fragile e incerta come un filo sottile che ci tiene aggrappati alla realtà.
Qual è la ragione per cui gli uomini si sentono attaccati?
In un mondo dominato da tragedie e dolore, è facile trovare un capro espiatorio su cui scaricare le proprie frustrazioni. Ciò che mi preoccupa di più è la tendenza a cercare colpevole anziché riflettere su come educare le nuove generazioni ad affrontare la fragilità umana senza puntare il dito contro mamme, papà, insegnanti o scuole. Siamo troppo propensi a emettere giudizi affrettati anziché metterci nei panni degli altri e cercare di capire le complessità che li hanno portati a compiere certe azioni.
In un’epoca in cui sembra più facile scagliare parole dure che fermarsi a riflettere, è importante non dimenticare di investire tempo ed energie nell’educazione delle giovani menti. Dovremmo cogliere l’occasione di tragedie come queste per promuovere la prevenzione, per aprire un dialogo costruttivo con i nostri figli e studenti, che peraltro sono direttamente colpiti da tali eventi. La prevenzione richiede sforzo e attenzione costante, ma è l’investimento più prezioso che possiamo fare per il futuro.
Tuttavia, temo che in un’epoca di slogan e superficialità, il tragico evento sarà presto dimenticato o ridotto a una serie di dichiarazioni vuote e prive di significato. Dobbiamo resistere alla tentazione di lasciarci trascinare dalla retorica semplicistica e concentrarci invece su una vera e propria riflessione che porti a un cambiamento reale.




